Francesco Lo Savio
Francesco Lo Savio (Roma, 28 gennaio 1935 – Marsiglia, 21 settembre 1963) è stato un artista italiano.
Biografia
Esordisce nel 1958 al "Premio Cinecittà", una mostra collettiva organizzata dal Partito comunista italiano, dove espone con Mario Schifano, Sergio Lombardo, Renato Mambor e Tano Festa, suo fratello. Grazie all'amicizia con Toti Scialoja, nel 1960 viene accolto nella galleria "La Salita", di Roma. Lo stesso anno la galleria "Selecta" di Roma gli dedica la prima personale ed espone in un'altra collettiva curata da Emilio Villa presso la galleria bolognese "Il Cancello". Nel 1961 inizia a esporre all'estero presso gallerie e musei.
Le sue opere successive, "palesemente anticipatrici della minimal art...non furono ben accolte dall'ambiente artistico" causandogli problemi economici e depressione che lo portarono a suicidarsi nel 1963, lo stesso anno in cui usciva, presso l'editore De Luca di Roma, il suo libro Spazio luce: evoluzione di un'idea, riedito da Einaudi nel 1975 a cura di Germano Celant.
Il suo successo postumo iniziò nel 1968 con la presenza a "Documenta 4", alla mostra Cento opere d'arte italiana dal futurismo a oggi della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, e alla sezione Linee della ricerca contemporanea della XXXIV Esposizione internazionale d'arte. Una sua retrospettiva curata da Germano Celant, inaugurò nel 1979 il Padiglione d'arte contemporanea di Milano. Altre retrospettive gli furono dedicate nel 2009 dal Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid e nel 2018 dal Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.
Francesco Lo Savio, dal libro “Spazio-Luce”, Roma 1962
Nel ‘54 cominciai i miei studi sull’architettura contemporanea, europea ed americana, sentendo precisi interessi per l’esperienza di Gropius relativa alla bauhaus, nei suoi rapporti col movimento de stjil e in particolare con l’opera di Mondrian.
L’interesse di questa esperienza era soprattutto ideologico e sociale. Le mie ricerche sui problemi dell’espressione formale si rivolsero invece al lavoro di Klee, Malevich, Gaudì, Le Corbusier, Maillart; e quando iniziai a lavorare (escluse alcune esperienze accademiche d’informazione) ero libero da ogni preconcetto formale, coerente esclusivamente a una concezione ideologica e sociale, derivata dalla mia partecipazione ai problemi d’evoluzione, sia concettuale che formale, dell’architettura e dell’industrial design.
L’idea d’impegnare uno spazio tridimensionale per realizzare un’esperienza biunivoca, interna come problema dell’espressione formale, esterna come problema del rapporto sociale, condiziona lo sviluppo del mio lavoro sotto un aspetto di discontinuità visiva, sia nella scelta dei mezzi che nel risultato di forma.
Nei dipinti su tela, diretti principalmente allo sviluppo di una concezione spaziale pura, dove la luce è l’unico elemento che definisce la strutturazione di superficie, tentando un contatto con lo spazio ambientale – realizzato mediante una situazione di differenti intensità cromatiche – l’elemento tridimensionale si configura attraverso un’immagine stereoscopica che puntualizza la situazione teorico-concettuale del rapporto tridimensionale.
 Roma - Perugia - Italia
Roma - Perugia - Italia
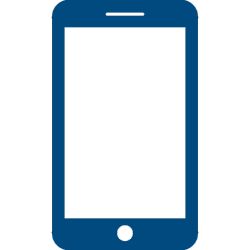 Tel: +39.338.6133623
Tel: +39.338.6133623 eMail: info@acquistoantiquariato.it
eMail: info@acquistoantiquariato.it ^
^